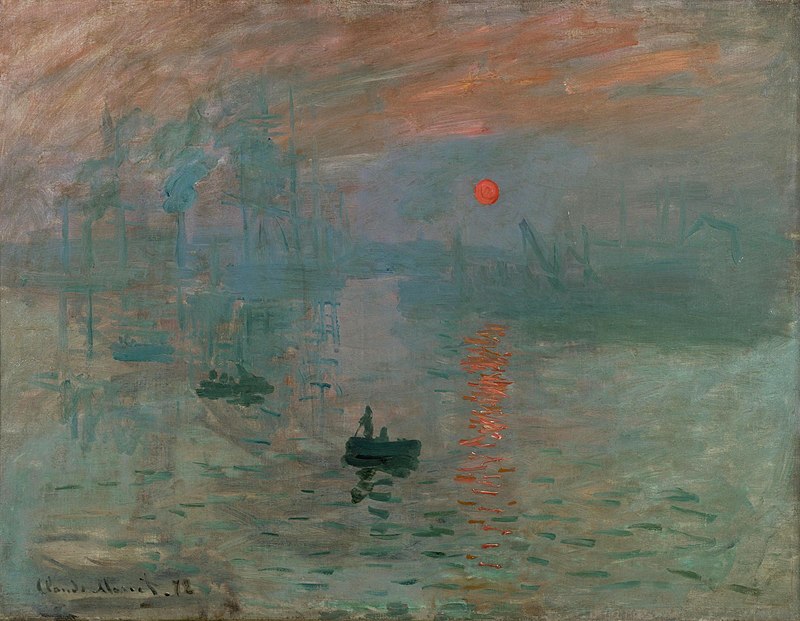
Senti Iolanda come è triste il sole
e come stride l’alito del vento –
passa radendo i vertici fioriti
un nembo irresistibile.
Senti, è sinistro il grido degli uccelli
vedi che oscura è l’aria
ed è fuliggine
nel raggio d’ogni luce e dal profondo
sembra levarsi tutto quanto è triste
e doloroso nel passato e tutte
le forze brute in fremito ribelle
contaminarsi irreparabilmente.
*
O vita, o vita ancor mi tieni, indarno
l’anima si divincola, ed indarno
cerca di penetrar il tuo mistero
cerca abbracciare in un amplesso immenso
ogni tuo aspetto. –
Amore e morte, l’universo e ‘l nulla
necessità crudele della vita
tu mi rifiuti.
*
Che ti valse la forte speranza, che ti valse la fede che non crolla
che ti valse la dura disciplina, l’ansia che t’arse il core
o mortale che chiedi la tua sorte, se dopo il tormento diuturno
se dopo la rinuncia estrema – non muore la brama insaziata
la forza bruta e selvaggia, se ancora nel tedio muto
insiste e vivo ti tiene; – perché tu senta la morte
tua ogni istante nell’ora che lenta scorre e mai finita
perché tu speri disperando e attenda ciò che non può venire
perché il dolore cieco più forte sia del dolore che vide
la stessa vanità di sé stesso? – Tu sei come colui che nella notte
vide l’oscurità vana ed attese da dio chiedendo la divina luce
e d’ora in ora il fiero cuor nutrendo
di più forte volere e la speranza
esaltando più viva, quando il giorno
con la luce pietosa
alla vita mortale
ogni cosa mortale riadulava
non ei si scosse che con l’occhio fiso
vedeva pur la notte senza stelle. –
Come il tuo corpo che il sole accarezza
gode ed accoglie avido la luce
perché non anche l’animo rivolgi
ai lieti e cari giochi? Vedi intorno
fin dove giunge il guardo, la campagna
ride alla luce amica.
*
Da Aprile
O vita, chi ti vive e chi ti gode
che per te nasce e vive ed ama e muore?
Ma ogni cosa sospingi senza posa
che la tua fame tiene, e che nel vario
desiderar continua si trasmuta.
Di sé ignara e del mondo desiosa
si volge a questo e a quello che nemico
le amica il vicendevole disio,
nemica a quelli pur quando li ami
e ancora a sé per più voler nemica.
Così nel giorno grigio si continua
ogni cosa che nasce moritura,
che in vari aspetti pur la vita tiene –
ed il tempo travolge – e mentre viva
vivendo muor la dïuturna morte.
Ed ancor io così perennemente
e vivo mi tramuto e mi dissolvo
e mentre assisto al mio dissolvimento
ad ogni istante soffro la mia morte.
E così attendo la mia primavera
una ed intera ed una gioia e un sole.
Voglio e non posso e spero senza fede.
*
Cade la pioggia triste e senza posa
a stilla a stilla
e si dissolve. Trema
la luce d’ogni cosa. Ed ogni cosa
sembra che debba
nell’ombra densa dileguare e quasi
nebbia bianchiccia perdersi e morire
mentre filtri voluttuosamente
oltre i diafani fili di pioggia
come lame d’acciaio vibranti.
Così l’anima mia si discolora
e si dissolve indefinitamente
che fra le tenui spire l’universo
volle abbracciare.
Ahi! che svanita come nebbia bianca
nell’ombra folta della notte eterna
è la natura e l’anima smarrita
palpita e soffre orribilmente sola
sola e cerca l’oblio.
*
Amico io guardo ancora all’orizzonte
dove il cielo ed il mare
la vita fondon infinitamente.
Guardo e chiedo la vita
la vita della mia forza selvaggia
perch’io plasmi il mio mondo e perché il sole
di me possa narrar l’ombra e le luci –
la vita che mi dia pace sicura
nella pienezza dell’essere.
E gli occhi tremuli della colomba
vedranno nella gioia e nella pace
l’abisso della mia forza selvaggia –
e le onde varie della mia esistenza
l’agiteranno or lievi or tempestose
come l’onda del mar l’alga marina
che le tenaci aggrappa
radici nell’abisso e ride al sole.–
(da Volo per altri cieli è la mia vita, poesie 1907-1910, Fara Editore, 1996)
Carlo Raimondo Michelstaedter nasce a Gorizia nel 1887. Si trasferisce a Firenze, dove si iscrive alla facoltà di Lettere. Approfondisce soprattutto Platone, i presocratici, la Bibbia, i tragici greci, Petrarca, Leopardi, Ibsen e Schopenhauer. In lui, questi studi contribuiscono in modo significativo alla maturazione di un solipsismo radicale che ha nella tragicità della finitezza umana il suo punto cardine.
Tornato nella sua città natale, Carlo si dedica alla stesura della tesi di laurea (La persuasione e la rettorica). In questo periodo, il suo male di vivere prende decisamente il sopravvento, portandolo al suicidio nel 1910.
Tra le opere più significative che ci ha lasciato si segnalano, oltre alla già citata tesi di laurea, il Dialogo della salute, alcuni scritti su Platone, un Epistolario e diverse poesie.
Michelstaedter non crede in un Dio d’amore, né in un suo riflesso efficace nell’uomo; in questo quadro, la dissoluzione nel nulla è l’unica via d’uscita al dramma dell’esistenza e alla negatività assoluta del mondo. Da tale consapevolezza, la maggioranza del genere umano prova a fuggire attraverso le confortanti illusioni del piacere, del potere, del divertimento, delle convenzioni culturali e sociali, rinunciando così al proprio esserci unico a favore di una “morte nella vita” che è l’alienazione nelle cose.
Strettamente legata al suo pensiero filosofico è la sua poesia, tutta intrisa di pessimismo e nichilismo e nonostante ciò ricca di immagini e di commovente bellezza.
Donatella Pezzino
Immagine: Impressione. Levar del sole, dipinto di Claude Monet, 1872.
Dalla mia rubrica “Caffè letterario” di Bibbia d’Asfalto alla pagina: https://poesiaurbana.altervista.org/carlo-michelstaedter-caffe-letterario/





























